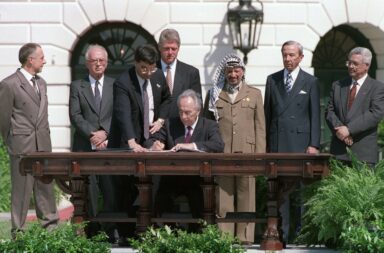Quest’anno cade il trentesimo anniversario della Guerra del Golfo, un episodio militare impressionante che segnò l’apice della stagione neoliberale inaugurata negli anni ‘80.
Il 17 gennaio scorso è caduto il trentesimo anniversario dell’avvio dell’operazione Desert Storm durante la Prima Guerra del Golfo, che era iniziata il 6 agosto 1990 con l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq di Saddam Hussein. A questa, rispose la controffensiva di una coalizione internazionale che, a seconda delle valutazioni sulla partecipazione dei singoli membri, andava da 31 a 40 stati – dove in ogni caso il grosso dello sforzo era sostenuto dagli Stati Uniti, con qualcosa come settecentomila truppe su quasi un milione di uomini impiegati. Anche l’Italia partecipò con la sua flotta aerea a questa guerra imperialista.
La prima guerra “dal vivo”, propriamente mediatica, trasmessa nelle televisioni di tutto il mondo quasi come un videogioco. Per la prima volta nella storia umana è possibile vedere con i propri occhi, in tempo reale, gli orrori delle guerre imperialiste. Ricordiamo in particolare i lampi di luce che illuminavano Bagdad e il terribile bombardamento del rifugio di Al Amiriya, nel quale sia erano rifugiate circa 1000 persone, donne, vecchi, bambini, con la speranza di salvarsi perché l’edificio era stato segnalato come struttura per la difesa civile. Purtroppo gli aerei statunitensi ignorarono questo fatto e circa 400 persone perirono bruciate.
Perché questa escalation di “guerra calda” dopo un periodo relativamente lungo, dopo la guerra del Vietnam, in cui non c’erano più interventi militari diretti così imponenti da parte delle potenze imperialiste?
L’Iraq era uscito spossato, ma sostanzialmente non indebolito sul piano politico, dalla lunga guerra d’aggressione contro l’Iran, durata tra il 1980 e il 1988, costata addirittura un milione di vittime. Aveva insomma ancora le risorse e la stabilità politica per proseguire nel suo tentativo di affermarsi come una potenza regionale non completamente sottoposta agli Stati Uniti e alla NATO, approfittando del crollo del Muro di Berlino e del processo di dissoluzione della vecchia spartizione mondiale di zone di influenza tra Unione Sovietica (che fu sciolta ufficialmente il 26 dicembre 1991, dieci mesi dopo la fine della guerra del golfo) e Stati Uniti. La stessa dinamica della guerra Iran-Iraq, con l’Iraq che riceveva fondi e armi contemporaneamente da URSS e USA, dimostrava che lo scenario politico mondiale andava verso un cambiamento d’epoca, e che nuovi spazi si aprivano per chi fosse riuscito ad accaparrarseli, e Saddam Hussein aveva capito che non c’era spazio per un’ascesa dell’Iraq come potenza regionale, se si fosse affermato nel Medio Oriente un equilibrio esageratamente pro-USA, con gli Stati arabi allineati come fedeli vassalli.
Rivendicando una unità nazionale tra Kuwait e Iraq, nonostante l’Iraq stesso avesse precedentemente riconosciuto ufficialmente il Kuwait, Saddam invase il piccolo Stato, che era ricchissimo di petrolio e, insieme a un possibile attacco alla confinante Arabia Saudita, avrebbe garantito all’Iraq la maggioranza netta del petrolio al momento estraibile in tutto il mondo. Un potere economico che avrebbe cambiato lo scenario geopolitico mondiale, se le potenze imperialiste sedi delle grandi aziende petrolifere occidentali non fossero intervenute.
Aldilà delle rivendicazioni ideologiche, d’altronde, l’Iraq era schiacciato da 90 miliardi di dollari di debito estero, di cui una fetta importante era in mano proprio al Kuwait. Quando nel luglio 1990, insieme agli Emirati, il Kuwait raddoppia la produzione di greggio per abbassarne il valore e mantenere alto il credito verso l’Iraq, la cui principale fonte di ricchezza è il denaro ricavato dalla vendita di petrolio, l’Iraq lo considera un gesto ostile e non aspetta oltre per passare all’invasione, che comincia il 2 agosto 1990.
Con la copertura diplomatica dell’ONU, che ricevette un rifiuto al suo ultimatum all’Iraq di ritirarsi dal Kuwait, la coalizione a guida USA poté rivendicare apertamente l’operazione militare che già aveva di fatto avviato, divisa sostanzialmente in tre fasi: quella “pacifica” pre-invasione dell’Iraq, Desert Shield (Scudo del deserto); quella di bombardamento a tappeto di obiettivi strategici iracheni, Desert Storm (Tempesta nel deserto, nome con cui è ricordata l’intera campagna) e Desert Sabre (Sciabola del deserto), cioè l’invasione terrestre.
Il risultato fu un trionfo clamoroso della coalizione: dal 7 agosto (quindi pochi giorni dopo l’aggressione irachena) al 16 gennaio 1991 furono trasportati nella zona d’operazione oltre 650.000 militari, migliaia di carri armati, mezzi leggeri e aerei, oltre che a una massa di materiale logistico paragonabile a quella per l’invasione della Normandia. Il Golfo Persico e il Mar Rosso si erano intanto riempiti con un centinaio tra portaerei, corazzate, incrociatori e sommergibili nucleari. La superiorità tecnologica, di mezzi e uomini portò a una sconfitta nettissima dell’Iraq, con un bilancio di morti e feriti che va agli oltre 100.000 iracheni contro nemmeno 2.000 della coalizione.
Da un punto di vista politico generale, possiamo vedere la prima guerra del golfo come l’ultimo, grande manifesto e trionfo del neoliberalismo nella sua fase di ascesa, dopo la lunga stagione degli anni Ottanta che ha visto una lunga, apparentemente inarrestabile offensiva politica della borghesia su scala mondiale per eliminare mano a mano le conquiste dei movimenti operai e popolari che avevano scosso il mondo fra gli anni Sessanta e Settanta. Dopo l’onta della sconfitta in Vietnam, la diplomazia americana e occidentale sembra inarrestabile, e nuove grandi rivoluzioni vittoriose come quelle della prima metà del secolo sembrano impossibili da mettere in atto, facilmente contenibili dall’apparato politico-militare dell’imperialismo o comunque deviabili su binari controrivoluzionari associati alla repressione violenta dei comunisti, come nel caso della rivoluzione iraniana.
Il 29 novembre 1990 il Consiglio di sicurezza approva la risoluzione 678 con cui si sancisce l’obiettivo di far ritirare l’esercito iracheno dal Kuwait “con ogni mezzo necessario” e si impone un ultimatum al 15 gennaio 1991.
Nel 1990, le potenze occidentali che ormai sono riuscite nell’obiettivo storico di far venire meno l’URSS e il suo enorme peso economico e geopolitico, sono ancora in grado di fare dell’ONU un proprio strumento del tutto docile, senza contraddizioni… o quasi: le eccezioni sono pochissime, vediamole.
L’Unione Sovietica è in disfacimento e ha bisogno di finanziamenti liquidi immediati: ne ottiene circa 4 miliardi dall’Arabia Saudita su intercessione americana e vota a favore. La Cina si astiene dietro la promessa di ottenere una normalizzazione dei rapporti diplomatici dopo l’isolamento di 18 mesi per la repressione della rivolta di piazza Tienanmen.
Solo due paesi votano contro: lo Yemen, unica repubblica fresca di unificazione, e Cuba. Il primo paese pagherà a caro prezzo questa opposizione, con il ritiro formale di tutti gli aiuti dell’FMI. Cuba è tutt’ora un paese accusato di terrorismo.
Insomma, alla faccia del primato dei diritti dell’uomo e della legge, della rule of Law come la chiamano gli anglosassoni, il semplice fatto che non ci fossero contropartite nella sintesi tra piano economico, politico e militare, era già un via libera più che sufficiente per poter risolvere gli attriti della scena politica mondiale con la violenza più concentrata e bruta possibile, come era stato nei momenti di massimo scontro tra le potenze imperialiste durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.
Dopo anni di cosiddetta fine della storia e logoramento di questo tappa mondiale dell’equilibrio capitalista, nel 2003 Bush figlio, emule dell’impresa del padre, non potrà contare sul via libera ufficiale dell’ONU e dovrà imbastire una coalizione “privata” a mo’ di parodia delle crociate che quanto meno, al loro tempo, erano benedette dal Papa, la massima autorità politico-diplomatica d’Europa.
Gli intellettuali liberali acclamarono questo trionfo della pace e della democrazia, insieme alla dissoluzione dei vecchi Stati operai europei burocratizzati, ma l’eredità della guerra del golfo e della nuova tappa che inaugurava ci ha portato a una disuguaglianza sociale ancora più accentuata a livello mondiale, con un rilancio dello sfruttamento e dell’arricchimento osceno di un pugno di miliardari che poteva contare da un lato sulle controriforme decennali nei paesi avanzati, e dall’altro sullo sfruttamento selvaggio delle nuove “selve vergini” dell’ex Patto di Varsavia, con la collaborazione sia della vecchia burocrazia del PCUS in gran parte riciclatasi come nuova borghesia russa, sia della più giovane e rampante burocrazia del partito comunista cinese, che aveva da tempo avviato le controriforme utili ad aprirsi ai colossali investimenti esteri occidentali e, in prospettiva, ad accumulare straordinari capitali, sempre più privati, per competere sul mercato internazionale e per aspirare in futuro a un posto stabile e riconosciuto tra le grandi potenze imperialiste.
I popoli del Medio Oriente, più di ogni altro, hanno vissuto invece sulla propria pelle la realtà che sta dietro alla favola della “nuova era di speranza e pace” che Bush e i suoi promettevano: interventi imperialisti e guerre civili interminabili, devastazione di interi paesi, depressione economica, migrazione di massa in condizioni aberranti. si pensi solo alle sanzioni che sono costate la vita a 500.000 bambini iracheni, un necessario prezzo da pagare secondo Madeleine Albright, ex segretario di Stato degli Usa, in cambio dell’esportazione della “democrazia.
È questa la vera eredità della guerra del golfo.
Giacomo Turci, Alessandra Ciattini
Articolo già apparso su La città futura
Versione scritta dell’intervento degli autori nella puntata di “Oltre confine” di Radio Quarantena del 20 gennaio.
Nato a Cesena nel 1992. Ha studiato antropologia e geografia all'Università di Bologna. Direttore della Voce delle Lotte, risiede a e insegna geografia a Roma nelle scuole superiori.