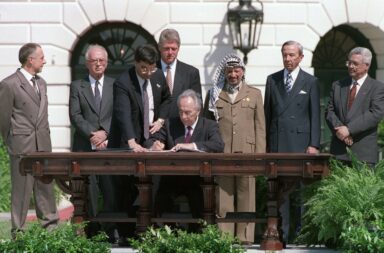Dal 2011, le organizzazioni dei lavoratori in Medio Oriente e i partiti della sinistra sono stati al centro dei movimenti per la democrazia e la giustizia sociale. Spesso denigrati dalla stampa occidentale, dall’Egitto alla Tunisia fino ad arrivare all’Algeria e Sudan, questi movimenti hanno portato avanti la loro lotta contro tremendi ostacoli. Proponiamo su questo tema un articolo di Joel Beinin, professore di storia alla Stanford University negli USA, che pubblicheremo in tre parti.
Il 14 gennaio 2020, in migliaia hanno marciato sulle vie principali di Tunisi per celebrare il nono anniversario della rivolta che ha portato alla caduta del dittatore Zine Abidine Ben Ali. Circondati da un cordone di forze di sicurezza, la folla non ha aizzato slogan politici. L’ordine era quello di esprimere l’orgoglio, il compimento e le speranze future della rivoluzione dei ‘gelsomini’.
A pochi metri di distanza, qualche centinaio di persone si erano radunate nella piazza di fronte alla sede della Federazione dell’Unione del Lavoro (acronimo francese di UGTT). Intonavano cori, “Lavoro! Libertà! Dignità!”: slogan rivoluzionari che suggerivano che gli obbiettivi della rivoluzione erano tutt’altro che raggiunti.
Il segretario generale dell’UGTT Noureddine Taboubi si rivolgeva alla folla, lamentando l’assenza di miglioramenti economici dalla caduta del regime nel 2011: “la rivoluzione andrà avanti finché non sarà instaurata una vera repubblica.” Mongi Merzouki, il segretario dell’Unione Nazionale dei Lavoratori dei Lavoratori dell’Igiene, interveniva sulla falsa riga di Tabbouni: “Sono molto deluso… abbiamo la libertà di espressione, ma non possiamo creare lavoro e sfamarci”.
Il sondaggio del 2018 condotto da OECD conferma ciò che denunciavano i leader dell’UGTT: le condizioni economiche non sono migliorate dalla caduta di Ben Ali, soprattutto nelle regioni occidentali e meridionale del paese e per i giovani e le donne. Gli investimenti sono crollati. Il tasso di disoccupazione nazionale va oltre il 15% e si attesta attorno al 30% per i giovani e oscilla tra il 20 e 30% nell’ovest e il sud del paese (simile alle condizioni pre-rivoluzione).
I salari reali sono crollati nella maggior dei settori, mentre la crescita annuale si attesta intorno all’1,7% dal 2011. Per garantire il ripagamento del prestito da 2,9 miliardi di dollari, il Fondo Monetario Internazionale ha preteso il congelamento dei salari e la svalutazione del Dinaro tunisino. La svalutazione monetaria ha spinto l’inflazione a un tasso annuo del 7,6% nel marzo 2018.
Le due manifestazioni del 14 gennaio incarnano la lotta sul significato delle sommosse arabe del 2010-11.
Stavano solo chiedendo democrazia e dignità? O erano anche movimenti per il lavoro, giustizia sociale e, implicitamente, rivolte contro le politiche neoliberiste e il capitalismo cronico? Quale fu il ruolo della classe lavoratrice della regione nelle proteste?
La politica economica della rivolta
Le azioni collettive dei lavoratori e dei disoccupati hanno costituito un’ampia parte dei movimenti che hanno cacciato Ben Ali in Tunisia, Mubarak in Egitto e che hanno sfidato le monarchie del Bahrain e del Marocco. I lavoratori raramente hanno preteso democrazia o un cambio di regime, fatta eccezione per il Bahrain dove la Federazione generale dei Sindacati del Bahrain (GFBTU) hanno avuto un orientamento a sinistra sin dalla loro fondazione nel 2004. Tuttavia i sempre più frequenti, e qualche volta lunghi scioperi, sit-in e proteste hanno contribuito ad una cultura della protesta che ha messo a repentaglio la legittimità dell’autorità al potere.
Le proteste popolari del 2018-20 in Sudan, Algeria, Libano e Iraq – e quelle, molto più brevi, in Tunisia ed Egitto – sono il continuo di quel ciclo di sommosse del 2010-11 e presentano le stesse rivendicazioni socio-economiche e politiche di quelle del 2010-11. Il capitalismo petrolifero concentrato in sei paesi del Golfo -Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuweit, Qatar, Bahrain e Oman- rimane la forza dominante dell’accumulazione di capitale nella regione anche se si sviluppa attraverso fasi di accumulazione primitiva basata sulla rendita di gas e petrolio.
I paesi poveri di Idrocarburi sono integrati all’interno del capitalismo petrolifero per mezzo delle rimesse economiche dei lavoratori emigrati e degli investimenti che i ricchi stati petroliferi fanno in questi paesi.
Questo tipo di dominazione di accumulazione di capitale è regolata, riprendendo le parole di Gilbert Achcar: “da un mix di patrimonialismo, nepotismo e capitalismo clanico insieme a atti di depredazione di proprietà pubbliche, grasse burocrazie e una corruzione generalizzata, il tutto all’interno di un background di grande instabilità sociopolitica e impotenza o addirittura assenza di stato di diritto”.
Aggiungerei a questa lista: basso indice di sviluppo umano, una cultura della repressione e la prevalenza dei movimenti islamisti come unica forma di opposizione politica.
I paesi poveri di idrocarburi sono soggetti sia agli stati ricchi di petrolio e sia dai grandi istituzioni finanziarie internazionali – FMI e Banca Mondiale – che sono sostenute da Unione Europea e Stati Uniti. Quando questi stati hanno bisogno di finanziamenti per salvare e coprire il loro debito estero (a causa di impennate dei prezzi delle importazioni di petrolio, per esempio) o per deficit del budget nazionale, il Fondo Monetario Internazionale spesso presta loro dei soldi a condizione che essi adottino politiche neo-liberali – fondate sulle politiche del Washington Consensus – spesso nominate come: Riforme Economiche e Programmi di Aggiustamento Strutturale (ERSAP).
Le ERSAP prevedono tagli alla spesa pubblica, privatizzazione del settore pubblico delle imprese, limitazione dei diritti dei lavoratori, riduzione o eliminazione dei sussidi governativi per i beni di prima necessità rendendo la valuta locale pienamente convertibile e facilitando investimenti stranieri.
Tali programmi sono essenzialmente politiche di austerità che pregiudicano l’investimento pubblico in occupazione e servizi motivate da un credo dogmatico che l’investimento privato è l’unica via che può risolvere tali incombenze.
Dopo le sommosse del 2010-11, il Fondo Monetario Internazionale ha riconosciuto che in passato aveva ignorato l’ineguale distribuzione dei benefici della crescita economica che stava promuovendo sin dagli anni ’70. L’ex direttore del Fondo, Christine Lagarde, scriveva sul blog del FMI: “consentitemi di essere sincera: non stiamo dando molta attenzione a come i frutti della crescita economica sono stati condivisi”. In pratica, tuttavia, il FMI ha semplicemente cambiato marchio alle stesse politiche che aveva proposto in passato definendole come “crescita inclusiva”.
L’asse della controrivoluzione
Uno dei maggiori cambiamenti del 2011 è l’alto profilo di Arabia Saudita ed Emirati Arabi nel rafforzare un ordine controrivoluzionario su scala regionale. La loro strategia puntava a costruire un “asse sunnita” settario – includendo il Bahrain, l’Egitto e, in maniera controversa, Israele, in opposizione al fronte iraniano e i suoi alleati regionali -Siria, Iraqi Houthi yemeniti, Hezbollah e i palestinesi di Hamas.
Nel 2011 l’asse sunnita è intervenuto militarmente per sopprimere la rivolta in Bahrain durante la protesta del 14 gennaio dei movimenti per la democrazia.
Nel 2015, hanno inviato truppe nello Yemen con l’obbiettivo di comabattere i ribelli Houthi e cercando di ristabilire il loro candidato al potere, nonostante le politiche saudite ed emiratine siano sempre state divergenti in Yemen.
I sauditi hanno, inoltre, sostenuto l’esercito egiziano e il presidente al-Sisi contro i Fratelli Musulmani, saliti al potere nella fase del post-Mubarak.
Nel 2017, i sauditi e gli Emirati hanno imposto un boicottaggio al Qatar (sunnita) accusandolo di supportare il terrorismo. L’atto d’accusa contro il Qatar era quella di aver adottato un atteggiamento benevolo rispetto all’Iran poiché, sia Qatar che Iran condividono nel Golfo Persico il più grande giacimento di gas (South Pars/North Dome).
Il Qatar, inoltre, ha impiegato ampie risorse per sostenere i movimenti islamisti nella regione come i Fratelli Musulmani in Egitto e il partito Ennahda in Tunisia i quali hanno abbracciato un Islam molto più moderato del wahhabismo saudita. Tuttavia, il boicottaggio del Qatar da parte di Arabia Saudita ed Emirati non ha funzionato. Ciononostante, gli alleati politici in Egitto e Siria sono stati sconfitti, mentre in Libia sono in guerra.
Ennahda è stata molto più vincente, dove ha vinto un ampio numero di voti nelle tre elezioni nazionali dal 2011. Nonostante il suo supporto a politiche anti-operaie e neo-liberali, Ennahda ha mantenuto una sua base nelle zone occidentali e meridionali del paese già impoverite e marginalizzate, tale resilienza potrebbe rispecchiare il supporto a Trump da parte dell’America rurale e della Rust Belt (vecchie città industriali degli Stati Uniti del nord vicino alla regione dei grandi laghi, marginalizzate per il declino industriale, letteralmente cintura arrugginita, ndr).
La rivolta tunisina
La rivolta del 2010-11 in Tunisia è iniziata nella desolata città di Sidi Bouzid nella regione centro-occidentale, nella quale il tasso di disoccupazione e di povertà era – e ancora è – molto maggiore rispetto al resto del paese. Mohamed Bouazizi, un giovane di 26 anni e venditore di frutta ambulante, si è dato fuoco davanti agli uffici del governo il 17 dicembre 2019, dopo che un ufficiale di polizia gli aveva confiscato il suo carrello con la frutta accusandolo di non avere il permesso di vendita in strada.
Le prime manifestazioni di solidarietà si tennero nei governatorati vicini. Il 4 gennaio 2011, morì per ustioni di terzo grado. Le precedenti manifestazioni di gennaio conversero in un movimento sociale nazionale che raggiunse, nella giornata del 6 gennaio, la capitale Tunisi.
Durante quelle settimane, la sempre più cooptata UGTT si limitò a fare appello alle forze di sicurezza di evitare l’uso della violenza. Tuttavia, altri leader di secondo ordine del sindacato e militanti regionali fecero fronte comune nella lotta. Misero a disposizione la loro esperienza politica, il supporto logistico e la loro struttura organizzativa al movimento sostenendo tutte le loro rivendicazioni di cambiamento. Dopo che Ben Ali fu deposto, il congresso del dicembre del 2011 dell’UGTT sostituì la vecchia guardia del comitato esecutivo con una nuova leadership orientata a sinistra.
Con oltre mezzo milione di membri, in un paese di 11 milioni di persone, l’UGTT è la più grande organizzazione civile del paese. La sua popolarità nell’opinione pubblica tunisina è molto più alta di qualsiasi partito politico. Nell’era post-Ben Ali, la leadership dell’UGTT ha appoggiato, in maniera molto prudente, sia le forze politiche secolari (incluse quelle neo-liberiste) contro gli islamisti di Ennahda, facendo pressione sul regime di non attuare politiche di austerità imposte dal FMI e contenere possibili proteste derivate dalla rabbia popolare.
L’UGTT ha costruito il suo status e legittimità rappresentando le rivendicazioni popolari al regime e convincendo lo stesso che, se non avesse accolto le istanze dell’organizzazione, la stessa non avrebbe garantito per la stabilità del paese.
Per portare avanti questa strategia, l’UGTT e la sua leadership hanno promosso azioni controllate, come ad esempio lo sciopero generale del 17 gennaio 2019, con il quale denunciavano il rifiuto del governo, sotto pressione del FMI di aumentare i salari di circa 670.000 lavoratori del settore pubblico. Lo sciopero permise all’UGTT di dimostrare che esso era dalla parte dei lavoratori pur restando all’interno dei limiti del gioco politico già in atto decenni addietro.
Una storia infinita
Tuttavia, le azioni di sciopero selvaggio, le quali non furono mai condannate dalla direziona nazionale dell’UGTT, furono le principali azioni che hanno messo a repentaglio la legittimità del regime di Ben Ali. Lo scoppio di rivolte popolari che rivendicavano lavoro e sviluppo economico sono scoppiate con una certa regolarità dopo la caduta del regime. In genere partivano dalla zona occidentale e meridionale del paese o in altre zone povere.
Il 16 gennaio del 2016, il ventottenne Ridha Yahyaoui, un neo-laureato senza lavoro, nel capoluogo della regione centro-orientale di Kasserine, aveva scoperto che il suo nome era scomparso dalla lista dei 75 candidati ad una posizione di lavoro nel settore pubblico. Per disperazione, si arrampicò su un palo della corrente e rimase fulminato.
Immediatamente, ebbero luogo proteste contro la mancanza di lavoro e assenza di opportunità economiche, seguite dal solito copione: sit-in, marce di protesta davanti alle sedi del governatorato, mentre due studenti universitari salirono sul tetto dell’università minacciando di suicidarsi. I giovani sfidarono il coprifuoco imposto e diedero fuoco agli uffici del partito di governo Nidda Tounes.
Con il passare dei giorni, il movimento si allargò nelle aree più prospere e politicamente influenti del paese, quelle della costa come Tunisi e Susa. Infine, le proteste si estesero in sedici dei ventiquattro governatorati, fino a quando il 22 gennaio cessarono.
Le proteste eruppero, dopo la morte di Yahyaoui, proprio come iniziarono quelle in solidarietà alla morte di Bouazizi che portarono alla caduta di Ben Ali. Entrambi i movimenti iniziarono nelle aree più marginalizzate prima di arrivare nella capitale del paese.
Una differenza, che emerge dalle proteste del 2010-11, è che in quelle del gennaio 2016 l’UGTT, la Lega Tunisina per i Diritti Umani, l’Unione dei Disoccupati Laureati e l’Unione Generale degli Studenti Tunisini si sono subito mosse con l’obbiettivo di sostenere le rivendicazioni ed evitare eventuali violenze.
Queste organizzazioni condividono, nonostante le numerose correnti e punti di vista, l’obbiettivo comune di mantenere il regime corrente invece di promuovere una instabilità che potrebbe far aumentare la popolarità dei movimenti islamisti (sia quelli legati a Ennahda che quelli jihadisti). Di contro, molti giovani nelle regioni periferiche sentono di non avere alcun legame o empatia con il regime.
“Cosa stiamo aspettando?”
Il 1 gennaio 2018, sotto una rinnovata pressione del FMI di attuare politiche di austerità, il governo aveva annunciato un bilancio che avrebbe aumentato le tasse sul carburante, schede telefoniche, sul prezzo delle case, le tariffe di internet, un aumento delle camere di albergo, e di voler ridurre i sussidi per frutta e vegetali. In risposta, l’8 gennaio, una protesta contro le politiche di austerità esplosero a Tebourba, un centro rurale a ovest della capitale Tunisi.
La sommossa si trasformò in un riot violento dopo che un uomo di 55 anni morì probabilmente a causa dei gas lacrimogeni. i riot si diffusero da Terbouna in almeno altre 20 località via social media con l’hashtag #fech_nestannew (cosa stiamo aspettando) e continuarono fino al 12 gennaio.
Oltre all’aumento dei prezzi, la mancanza di posti di lavoro, soprattutto per i neo-laureati, furono le principali cause delle proteste. A Terbouna, Oussema Ellafi, un disoccupato di 32 anni musicista aveva affermato: “abbiamo parlato pacificamente con le persone e abbiamo detto dateci un lavoro; abbiamo presentato le domande di lavoro e abbiamo detto che siamo laureati e diplomati, e non è successo niente. Quelle cose pacifiche non hanno risolto niente”.
Imen Mhamdi, ventisette anni, laureato all’università, attualmente impiegato come operaio, ha detto di essersi unito alle manifestazioni a Sousse perché “questo governo, come ogni governo dopo Ben Ali, non fa altro che promettere e non ha fatto nulla”.
Unità o commedia?
Dopo la protesta di Terbouna, l’UGTT ha messo pressione al governo mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi sulle classi meno abbienti. Il compromesso venuto fuori, tipico del modo di fare dell’UGTT, fu quello di una promessa governativa di aumentare l’assistenza a 250.000 famiglie povere con l’investimento di 70,3 milioni di dollari e la garanzia di servizi sanitari gratuiti.
Il Fronte Popolare è un’alleanza di partiti della sinistra che hanno costituito, prima delle elezioni del 2019, il più grande blocco di opposizione in parlamento, occupando 15 dei 217 seggi disponibili. Il blocco ha apertamente sostenuto le proteste di Terbouna e ha cercato di allargarlo e coordinarlo insieme ad altri che lo sostenevano. Il Fronte Popolare ha etichettato il compromesso approvato dall’UGTT come una buffonata. Nonostante ciò non è riuscita a mobilitare altre azioni contro il compromesso.
Il Fronte Popolare si è separato dopo le elezioni del 2019. Uno dei principali componenti, Il Movimento del Popolo, si è aggiudicato 15 seggi in parlamento, mentre il Fronte Popolare originale occupa un solo seggio. Tuttavia, quest’ultimo, nel febbraio del 2020, si è coalizzato con le forze del governo.
Tale coalizione include Ennahda e altri partiti inclini a sottostare ai dettami del FMI che sta, attualmente, proponendo alla Tunisia, un ulteriore prestito di 3 miliardi per far fronte alle spese di governo per il 2020.
Sicuramente questo porterà di nuovo nel campo della contestazione.
Joel Beinin
Traduzione da Jacobin
La Voce delle Lotte ospita i contributi politici, le cronache, le corrispondenze di centinaia compagni e compagne dall'Italia e dall'estero, così come una selezione di materiali della Rete Internazionale di giornali online La Izquierda Diario, di cui facciamo parte.