Prima che la pandemia di coronavirus scoppiasse in Italia all’inizio di quest’anno, Iside Gjergji ha pubblicato Sociologia della tortura. Immagine e pratica del supplizio postmoderno, a cura di delle edizioni dell’università di Venezia Ca’Foscari [qui liberamente scaricabile in pdf]. In quest’opera l’autrice non considera i corpi torturati come oggetti soggiogati dal potere, ma come corpi che rivelano l’appartenenza a una classe sociale. Per questo parla di “corpo-classe“, un concetto che le permette di comprendere i fondamenti della persistenza storica della tortura come fenomeno sociologico.
Pubblichiamo di seguito un’intervista a Iside realizzata da Andrea D’Atri, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) d’Argentina e della corrente femminista socialista internazionale Pan y Rosas.
Abbiamo avuto l’opportunità di incontrarci a Roma, dove, espresso alla mano, abbiamo discusso dell’ultimo lavoro di Iside. Abbiamo parlato del Cile di Pinochet, dove la teoria dei Chicago Boys combinava il neoliberalismo con la dittatura e la tortura; dell’Iraq, che è diventato lo Stato che è “il sogno di ogni capitalista” per i propri investimenti, mentre la polizia militare statunitense, gli agenti della CIA e gli appaltatori militari torturavano i prigionieri iracheni ad Abu Ghraib. Abbiamo anche parlato della sua adolescenza negli anni ’80 in Albania e non solo, in un caffè del trafficato quartiere Esquilino, oggi frequentato più dagli immigrati che dai turisti benestanti.

L’intervista di Andrea a Iside a Roma.
Iside Gjergji è nata in Albania ed è emigrata in Italia a sedici anni. È una sociologa e una giurista. Il suo lavoro come studiosa e docente si occupa di migrazione, lavoro, razzismo e teoria sociale. Ha insegnato all’Università di Stanford (USA) ed è ricercatrice presso il Centro di Studi Sociali dell’Università di Coimbra (Portogallo). Ha pubblicato Sulla governance delle migrazioni. Sociologia dell’underworld del comando globale, con Franco Angeli (2016) e «Uccidete Sartre!». Anticolonialismo e antirazzismo di un «revenant» (2018). In questa occasione, iniziamo parlando del suo ultimo libro.
***
Qual è la tesi di questo nuovo libro che hai pubblicato di recente?
La tesi principale del libro non è quella di considerare la tortura come espressione del male innato dell’essere umano, ma come un fenomeno sociale che non si applica a un corpo qualsiasi. In tutte le coordinate geografiche e in tutti i tempi storici, la tortura è quasi sempre applicata ai corpi delle classi che tengono in piedi il sistema produttivo. Dalla schiavitù ad oggi, coloro che sono stati torturati in massa sono sempre stati i corpi proletari. E mentre ci sono alcuni casi di tortura di piccoli borghesi o di borghesi, questi sono coloro che difendono la causa degli sfruttati, cioè vengono torturati perché considerati traditori della loro classe. Questi casi non invalidano la tesi secondo cui la tortura viene applicata, in modo particolare, contro una parte della popolazione e questa parte della popolazione – dall’antichità ad oggi – è sempre stata quella degli sfruttati. Questa è la prova che la tortura è sempre direttamente legata all’economia, al sistema produttivo e non alla forma di regimi politici o istituzionali. Qualunque sia l’istituzionalità o la forma di governo, la tortura ha sempre colpito lo stesso segmento della popolazione.
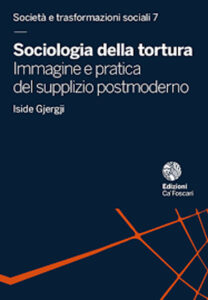
Nella schiavitù, la tortura era una condizione sine qua non: la schiavitù non può essere compresa senza la tortura. In ogni circostanza, come ha detto un autore americano, la tortura era la tecnologia dell’epoca, quella che permetteva di aumentare la produttività dello schiavo. In America, la produzione di massa è stata introdotta attraverso la schiavitù degli africani deportati in massa, prima ancora che si sviluppassero le grandi fabbriche capitaliste in Europa. Nelle piantagioni, dove in una singola azienda lavoravano fino a 50.000 persone schiavizzate, la tecnologia introdotta sistematicamente, che permetteva di aumentare la produttività, era una tortura.
Fin dall’inizio del libro, l’autrice sottolinea questo scopo della tortura: “[ha] sempre come obiettivo finale la disumanizzazione delle vittime e dei gruppi sociali ai quali esse appartengono, così come – ed questa è la prospettiva particolare del libro – il controllo e la svalorizzazione della loro forza lavoro[1].
Come si esprime questo rapporto nel proletariato oggi?
La tortura ha subito, come tutte le altre sfere dell’esistenza sotto il capitalismo, le trasformazioni del modo di produzione. Quindi, se c’è un passaggio dal fordismo al post-fordismo, le stesse variazioni si ritrovano nella tortura. La tortura postmoderna, a differenza di quella moderna, è praticata da un gran numero di specialisti e c’è una maggiore divisione del lavoro che tende – almeno idealmente – ad ottenere un risultato just in time. Il lavoro è segmentato: c’è un elettricista che si occupa della tensione, uno psicologo che deve valutare il punto di rottura o rottura dell’equilibrio mentale del torturato, ecc. Anche l’aspetto psicologico della tortura è più importante. Questo passaggio dal corpo alla mente, l’ultra-segmentazione nella divisione del lavoro e il tentativo implicito dell’effetto just in time fanno della tortura un elemento che si sovrappone al modello produttivo, compresa una fortissima tendenza alla privatizzazione. Non solo lo Stato ha il potere di torturare, ma delega anche il controllo sociale, le carceri, alle imprese private. La tortura è praticamente privatizzata.
Questo rapporto che si instaura tra la tortura di massa e le classi sfruttate contesta o si oppone all’idea di biopolitica…
Sì, è una tesi che va molto contro il pensiero che si è sviluppato sulla violenza della tortura, dove le teorie di Foucault e Agamben sono egemoniche. Critico fortemente queste teorie, sulla base del pensiero di Marx. Questi autori, in generale, non considerano mai il corpo all’interno delle dinamiche sociali. Al contrario di Marx che – in diversi testi, ma in particolare nel primo libro de Il Capitale – ha spiegato che il corpo ha una storia sociale. E dire questo significa tenere conto dei segni che la gerarchia economica e sociale del capitale imprime a questi organismi. Anche se Marx non lo ha reso esplicito, mi sembra che si possa parlare di “corpo-classe”. Ed è proprio su questa “classe corporea” che la tortura punta.
Dico che il primo a parlare di biopolitica è stato Marx, quando ha considerato il corpo all’interno della fabbrica, al lavoro, come un corpo che ha una storia sociale. Non sono corpi detenuti da un potere generico; sono corpi che sviluppano un certo compito, la cui muscolatura è addirittura modellata dai movimenti a cui è sottoposta in quell’opera.
Nel suo libro, Iside scrive a questo proposito: “Si tratta di una corporeità manipolata dal capitale che diventa, in ogni aspetto, subalterna ai suoi andamenti e processi (Finelli, Toto 2012). Partendo da questa idea di corporeità, Marx “mette in scena un’altra biopolitica” (Bidet 2012, 58) ,che non esclude il ruolo dello Stato, dei tecnici, del potere e del diritto dall’analisi, ma che completa il quadro collocando al suo interno altri elementi, in grado di rendere visibili i segni e le gerarchie imposte dal capitale.
Mettendo in campo la biopolitica marxiana – all’interno della quale i corpi non sono semplici corpi, ma corpi-al-lavoro (Bidet 2012) – si può costruire anche un punto di vista sulla tortura: questa può essere ora osservata come un fenomeno sociale collocato all’interno delle dinamiche del mercato, perché i corpi dei torturati – sia prima che dopo l’atto di tortura – sono oggettivamente immersi in queste dinamiche[2].
Iside fornisce diversi esempi storici e poi afferma: In ogni tentativo di ristrutturare il sistema capitalistico, la tortura entra in gioco.
Cosa c’entra questo con il tuo lavoro sulla migrazione?
Sempre la violenza intensa e costante contro gli immigrati assume la forma della violenza della tortura. C’è un rapporto intimo tra razzismo e tortura, un rapporto storico che nasce e si solidifica con il colonialismo e fa della tortura l’estrema verità del razzismo. È Sartre che ha formulato una definizione più audace e rigorosa del razzismo come violenza. Non la considera un’ideologia, come fanno altri teorici. Sartre, invece, dice che il razzismo è una violenza giustificata da un’ideologia. Non può essere pensata solo come un’ideologia, perché il razzismo è sempre un’operazione materiale. Posso pensare al razzismo come a un’ideologia, ma chiunque abbia subito il razzismo nella propria pelle lo vive soprattutto come violenza, sia materiale che simbolica. Se stai dietro all’esercito imperialista coloniale sentirai solo parole razziste, ideologia; ma se stai davanti a quell’esercito, se sei la vittima, sentirai tutta la violenza. La fonte primaria di tale violenza è lo Stato e, in un sistema di produzione capitalistico, la violenza è subordinata allo sviluppo del capitale.
Nelle parole del suo libro: “Per rapinare le terre e le risorse delle colonie nonché per sfruttare al massimo la manodopera locale occorreva creare un sistema che fosse in grado di ridurre i colonizzati in sotto-uomini, cose, lavoratori sottomessi e ubbidienti. La risposta a tale bisogno strutturale del colonialismo fu il razzismo; si ribadisce, non un razzismo inteso come semplice paura dell’altro, ideologia o credenza, ma un razzismo-operazione che poggiasse interamente sulla violenza, che fosse esso stesso violenza, una violenza complessa con giustificazione incorporata[3].
La conversazione ci porta alle rivolte negli Stati Uniti contro la polizia. Iside riflette su come Trump usi la stessa struttura “opaca” al di fuori della legge, che usa al confine messicano contro gli immigrati latinoamericani, ora contro i manifestanti che sono diventati il “nemico interno”.
Proseguiamo parlando dei focolai del coronavirus nello Stato spagnolo, situati nei luoghi dove si concentrano i lavoratori agricoli stagionali. In alcune regioni dell’Europa meridionale, sono lavoratori provenienti dal Marocco e da altri paesi africani. Ma ci sono anche migranti provenienti dagli Stati dell’Est che un tempo erano sotto l’orbita dell’ex-Unione Sovietica. I lavoratori rumeni e polacchi non sono in grado di prevenire la discriminazione in Europa occidentale e il sovrasfruttamento da parte dei datori di lavoro agricoli a causa del colore della loro pelle. A questo proposito, ricordo che Iside è nata in Albania ed è emigrata in Italia nel 1991, con la sua famiglia, all’età di 16 anni.
Che ricordi ha come migrante albanese in Italia? Com’è stato passare da uno Stato burocratico operaio a un paese capitalista?
Non parlo molto di quel periodo. L’Italia era molto conosciuta attraverso la televisione. Eravamo molto ben informati, perché la mia famiglia aveva un’antenna che ci permetteva di guardare la televisione italiana. Era una pratica clandestina, ma di massa! La finestra era coperta da una tenda scura, perché la trasmissione della televisione albanese terminava alle dieci di sera; quindi, bisognava evitare che si potessero scorgere da fuori televisori accesi dopo quell’ora. Inoltre, mio padre, che era un insegnante di lingua, mi aveva insegnato l’italiano; così quando sono arrivata lo parlao perfettamente. Questo ha limitato lo shock del disorientamento, dell’incapacità di decifrare il codice altrui.
La crisi economica nei paesi stalinisti, mal definiti del “socialismo reale”, andava avanti da diversi anni. Si poteva mangiare un chilo di carne al mese, per ogni famiglia di quattro persone, e anche questo non era garantito! Nella mia memoria ho il ricordo di aver passato molte, molte notti con mio fratello in coda per essere in anticipo e per poter comprare il cibo prima che finisse.

Iside Gjergji a 3 anni a Durazzo, Albania. Dietro di lei c’è un cartello che recita: “Verso il 22° Congresso regionale del Partito con il piano di 9 mesi realizzato in tutti i suoi indicatori”.
Il clima era quello di uno Stato dittatoriale, basato su una repressione che aveva, ad ogni livello, un aspetto di follia irrazionale. Era un controllo sociale capillare a tutti i livelli, esteso a tal punto che era difficile non impazzire, perché c’erano vicini che denunciavano non solo questioni strettamente politiche: entravano in gioco questioni personali, banali, di gelosia, di invidia… Ci si trovava così con numero esorbitante di “nemici del popolo”, davvero difficile da inquadrare in senso stretto. Questo è ciò che ha reso il sistema ingovernabile. Perché se metà della popolazione è una spia, nessuno riuscirà a controllarla. Tutto è lasciato alla decisione discrezionale del funzionario che decide tutto. Il modello stalinista di repressione in Albania è stato il più parossistico di tutti i paesi del “socialismo reale”. Mio padre era considerato “nemico del popolo”, era uno scrittore, un anarchico, che aveva studiato in Unione Sovietica dopo la guerra, dove si sono formati i quadri del Partito comunista. Insegnava all’università e mia madre era commissario politico del Ministero dell’Istruzione. Il fratello di mia madre era in prigione per motivi politici, mio nonno fu espulso dal partito anche se era stato commissario politico della Brigata Gramsci nella resistenza contro il nazismo[4]. Per tutta la vita sono stati etichettati come comunisti che non applicavano bene la “lotta di classe”. A mio padre fu proibito di parlare in pubblico, non poté più pubblicare e fu espulso dall’università e dalla scuola dove insegnava; finì per lavorare per molti anni come operaio in una fabbrica di plastica. Mia madre è stata degradata a maestra elementare perché rimase con mio padre. Doveva insegnare in un posto sperduto, dove doveva camminare per tre ore perché non c’erano mezzi di trasporto: usciva di casa la mattina presto e rincasava la sera.
Se una persona andava in prigione, lo stigma era su tutto il clan della famiglia. A un certo punto questa politica è andata in crisi perché c’erano solo due milioni di persone, quindi a un certo punto tutti sono stati puniti dalla repressione! Perciò, ho assistito a numerosi episodi di questa repressione… Per esempio, non ho potuto essere eletta rappresentante della mia classe dai miei compagni di classe. Una volta sono stata eletta e l’amministrazione della scuola ha annullato l’elezione; la votazione si è svolta di nuovo e i miei compagni di classe mi hanno eletta di nuovo, così sono venuti in classe con la polizia e, al terzo tentativo, hanno votato per un’altra ragazza. Molti insegnanti non mi hanno dato il massimo dei voti, anche se andavo molto bene a scuola, in modo che la gente non pensasse di favorire un “nemico della lotta di classe”. In Albania non avevo il diritto di andare all’università perché era il partito a darti questo diritto e a decidere cosa dovessi studiare secondo le esigenze dello Stato. Questo è stato anche uno dei motivi per cui i miei genitori hanno deciso di emigrare.
Ma c’è una cosa che, dopo un breve periodo di tempo in Italia, ho capito essere una differenza radicale tra questa società e la società albanese. Con tutte le critiche feroci che posso fare allo stalinismo, quella era una società in cui sia i miei genitori che la mia generazione non avevano avuto una “esperienza padronale”. Lo Stato era come un proprietario, sì; ma questo era qualcosa di molto astratto. C’era quindi un’incapacità antropologica, sia mia che dei miei genitori, di concepire un rapporto umano e sociale di cui facesse parte il capitale. In Albania ciò che ha fatto la differenza è stato lo status sociale, per esempio, essere un leader di partito; ma non è stato il capitale a fare la differenza. Lavorare in un negozio, in un’azienda, sotto l’autorità di un datore di lavoro, era qualcosa di veramente difficile da capire, persino da accettare. Non si trattava di ribellione sociale, ma di totale alienazione. Credo che ciò abbia dato origine a una reputazione molto negativa che si è rapidamente costruita negli anni ’90 sugli immigrati albanesi in Italia, considerati ingrati, come persone che non riconoscevano i favori che venivano loro fatti, che non erano obbedienti e che pensavano con la loro testa. Ovviamente, queste caratteristiche erano un problema in Italia: gli albanesi riconoscevano l’autorità di un direttore, ma non di un proprietario!
La conversazione ci porta alla religione e all’ateismo di Stato dell’Albania. Parliamo della sua bisnonna turca, una giovane musulmana fuggita in Albania nel 1900 per non essere sposata con un uomo più anziano. Parliamo anche del suo bisnonno, che era americano-irlandese. Tra le tante avventure del clan familiare, le dico che dovrebbe davvero rinunciare ai saggi sociologici e lanciarsi nella scrittura di un romanzo. Ridendo, mi dice che i mesi di reclusione per il coronavirus avrebbero potuto essere un buon periodo, ma che la moltiplicazione del lavoro domestico sarebbe stata un grande ostacolo.
“È la prima volta che parlo della mia esperienza”, mi confida Iside. Quindi, la ringrazio per la fiducia. Dopo tutto, anche il suo prolifico lavoro di sociologa, docente e ricercatrice, e il suo impegno a lottare per uno dei settori più sfruttati della classe operaia europea, quello degli immigrati, sono il risultato di queste esperienze, sradicamento, ricordi e viaggi.
Va notato che la tortura non è un fatto antisociale, ma un fatto determinato dalle relazioni sociali. La tortura – proibita, criminalizzata e condannata ovunque – si nutre quindi di forze e pressioni che nascono nelle viscere del sistema produttivo e dei rapporti sociali che lo accompagnano; legge, morale, etica e politica non sono semplici barriere da superare o, se necessario, da demolire. Se non si eliminano le condizioni strutturali che rendono invincibile la tortura, parlare della sua abolizione sarà sempre una menzogna.
Intervista a cura di Andrea D’Atri già apparsa su Ideas de Izquierda
Note
1. I. Gjergji (2019), Sociologia della tortura. Immagine e pratica del supplizio postmoderno, Edizione Ca’Foscari, Venezia, p. 13.
2. Ibidem, p. 53.
3. Ibidem, p. 58.
4. La Brigata Antonio Gramsci fu formato nel novembre 1943 da soldati italiani che decisero di resistere alle forze naziste in Albania. Tra i comandanti c’era anche un guerrigliero albanese. Questo battaglione era considerato un corpo d’elite delle forze partigiane. Nel 1944 il battaglione partecipò alle operazioni di liberazione di Tirana, capitale dell’Albania.
5. Ibidem, p. 88.
Nata nel 1967 a Buenos Aires, dove tuttora vive. Laureata in Piscologia alla UBA, specializzata in Studi sulla Donna, ha lavorato come ricercatrice, docente e nel campo della comunicazione. È dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Militante di lungo corso del movimento delle donne, nel 2003 ha fondato la corrente Pan y Rosas in Argentina, che ha una presenza anche in Cile, Brasile, Messico, Bolivia, Uruguay, Perù, Costa Rica, Venezuela, Germania, Spagna, Francia, Italia.
Ha tenuto conferenze e seminari in America Latina ed Europa.
Autrice di "Pan y Rosas", pubblicato e tradotto in più paesi e lingue. Ha curato il volume "Luchadoras. Historias de mujeres que hicieron historia" (2006), pubblicato in Argentina, Brasile, Venezuela e Spagna (2006).
Nata a Durazzo, in Albania, si trasferisce in Italia nel 1991. Laureata in Giurisprudenza all'Università di Bari, dottorato in sociologia all'Università del Salento, come ricercatrice studia il fenomeno migratorio presso varie università, in particolare a Venezia e a Coimbra. Autrice, tra l'altro, di "Uccidete Sartre!". Anticolonialismo e antirazzismo di un revenant", Ombre Corte (2018) e "Sulla governance delle migrazioni. Sociologia dell'underworld del comando globale", Franco Angeli (2016).





