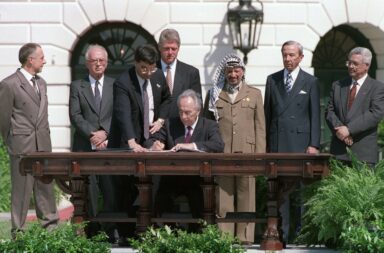Ogni volta che si entra in un periodo di crisi economica, numerosi opinionisti indignati rispolverano il trito e ritrito mantra per cui il capitalismo non starebbe funzionando. Ma è vero? Osservando le motivazioni che animano quest’idea, si scopre una realtà piuttosto deludente, che rimuove del tutto il bisogno del processo rivoluzionario.
È un luogo comune che periodicamente torna a farsi strada nel dibattito pubblico, in corrispondenza di circostanze ben precise. Lo abbiamo sentito ripetere molte volte nel 2008, in seguito al crollo della borsa di Wall Street, e lo stiamo sentendo sempre di più in questi giorni, nel bel mezzo della crisi economico-sanitaria causata dal Covid-19. “Il capitalismo non funziona più”. Le argomentazioni a sostegno di questa tesi sono, in linea di massima, l’aumento delle ineguaglianze economiche e sociali, l’emergenza climatica, il dominio della finanza sulla politica e sull’economia reale, l’incapacità di salvaguardare la salute delle persone e il sempre maggiore divario con l’1% più ricco.
Prima di entrare nel merito, però, vale la pena fare un po’ di storia: la retorica sul malfunzionamento del capitalismo riprese a diffondersi da prima dello scoppio della pandemia, nel settembre del 2019, quando il Financial Times pubblicò un articolo di Martin Wolf dal titolo Perché il capitalismo truccato sta danneggiando la democrazie liberale. In sintesi, l’economista statunitense presentava delle riflessioni a partire dal resoconto della US Businnes Roundtable, conferenza dei CEO delle 181 più grandi aziende del mondo, che dichiararono di voler abbandonare il principio per cui le società per azioni esistono al solo scopo di servire gli azionisti. Per Wolf, il fatto che si fosse arrivati a un simile spartiacque indicava che qualcosa era andato storto nel sistema. Le maggiori aziende e multinazionali avevano alterato il naturale corso del capitalismo preferendo la rendita alla produzione di ricchezza; il mercato finanziario si sarebbe quindi ingrandito a dismisura, mettendo in grave difficoltà le banche (costrette a concedere sempre più credito) e i governi (costretti a mettere in agenda i bilanci, prima del benessere pubblico). Insomma, nessuno aveva tratto la giusta lezione dalla crisi del 2008. Interessante notare come i media liberal-progressisti nostrani, The Vision e Il Post, avevano riportato la notizia all’epoca. L’urgenza del problema evidenziato da Wolf derivava dal fatto che erano gli stessi capitalisti a dirci che il capitalismo non stava funzionando. La soluzione? “Capire come lo aggiustiamo, questo capitalismo”.
Tenendo bene a mente questo contesto minimo, esaminiamo ora il cuore della questione. Cosa vuol dire, dunque, per un sistema economico “funzionare”? La risposta a questa domanda forse sarebbe così vaga e astratta da impedirci di proseguire, quindi proviamo a ridurla in questo modo: cosa significa per quel particolare e storicamente determinato sistema economico che è il capitalismo “funzionare”? Per rispondere – in maniera un po’ pedante e didascalica – partiamo da una definizione di “capitalismo”, semplice (ma non troppo) e ampiamente condivisibile. Ecco quella del Vocabolario Treccani:
sistema economico caratterizzato da ampia e sistematica applicazione di capitale di proprietà privata alla produzione, al fine di destinare il surplus al successivo ciclo produttivo anziché al consumo, dalla libera concorrenza su tutti i mercati e dalla separazione tra classe detentrice dei capitali e classe dei lavoratori.
Ora, anche limitandoci al periodo che va da febbraio a oggi, pare che i fatti soddisfino tutti gli elementi presentati dalla definizione. L’esistenza del capitale, sia come ricchezza accumulata che come insieme di beni economici destinati alla produzione, non è mai stata messa in discussione, tantomeno quella della proprietà privata. Lo stesso vale per libera concorrenza e libero mercato e va da sé che la separazione tra le due classi fondamentali non solo si è conservata, ma è aumentata a dismisura. È invece praticamente impossibile trovare una qualsiasi definizione di capitalismo che includa la salvaguardia dell’ambiente e la salute delle persone.
Il problema quindi sembra risiedere nel reimpiego del surplus all’interno dei cicli produttivi. Buona parte dell’argomentazione di Wolf e seguaci si regge proprio sul fatto che, negli ultimi tempi, questo non sarebbe avvenuto; il nuovo valore prodotto dall’economia globale non è più stato investito per alimentare lo sviluppo e l’innovazione, ma è invece finito tutto nei mercati azionari e nella speculazione. Questo a causa della deplorevole condotta dei capitalisti, i quali preferiscono la garanzia di un profitto nel breve termine al lungo e laborioso processo che porta al progresso dell’economia reale.
Per capire dove si annidano i problemi di questa interpretazione, dobbiamo riflettere sul concetto di crisi. Chi crede che il capitalismo non stia funzionando pensa che la crisi sia grosso modo un’avaria, un guasto, quando, in realtà, il capitalismo vive dell’alternanza di fasi: ristagno, ripresa, prosperità, crisi, recessione, poi di nuovo ristagno, ripresa ecc. Certo, questo non vuol dire che i periodi di crisi non portino con essi sfaldamento, debito, inflazione e disgregazione economico-sociale, ma il punto sta nel riuscire a scorgere in questi processi le opportunità per la ristrutturazione a partire dalle quali il capitalismo ha sempre riavviato il proprio ciclo.
Veniamo al punto: la finanziarizzazione è forse un difetto dovuto all’inadempienza dei capitalisti? No, è una conseguenza della saturazione dei mercati, la quale, al picco del periodo di prosperità, rende più difficile la vendita di merci. In tali circostanze, capitalisti rinunciano a investire, riducono la produzione (alimentando così la disoccupazione) e si rivolgono altrove per la ricerca di profitti. Questo “altrove” è proprio il mercato finanziario, dove si possono vendere azioni a un prezzo estremamente vantaggioso dal momento che i tassi d’interesse nel frattempo si sono alzati. E questo perché? Perché, nella cosiddetta fase di recessione, il mercato reale non genera più gli introiti necessari a pagare i debiti e si ricorre massicciamente al credito; le banche sono quindi costrette ad alzare i tassi d’interesse per non esaurire le loro riserve. Ad un certo punto, nel corso di questo periodo di ristagno, l’offerta di merci sorpassa la domanda al ribasso. Questo porta a un aumento dei prezzi e, di conseguenza, dei margini di profitto. Si entra così in ripresa: conviene di nuovo investire e comprare forza-lavoro e il ciclo può ripetersi (di solito in scala maggiore di prima). Certo, oggi le riserve delle banche centrali non costituiscono più una limitazione, quindi non è raro assistere a gettiti fiscali multimiliardari con tassi di interesse fissi o addirittura ribassati. Ma questo, semmai, più che una “falla” nel sistema, è il portato di un processo adattativo che ha permesso al capitale di attutire artificialmente gli effetti della crisi e di ridurre i tempi di ripresa. Per quanto riguarda i capitalisti monetari, invece, lungi dall’essere una razza aberrante, essi sono componente integrante del sistema (concedono prestiti a fianco delle banche).
Se si guardano i dati odierni sui tassi di profitto delle società statunitensi il quadro diviene ancora più chiaro: dopo la caduta dello scorso quadrimestre, i tassi di profitto sono saliti del 27,5%, uno scarto che non si vedeva dal 2009, proprio quando iniziava la ripresa dal crollo di Wall Street. I fondi disponibili per l’investimento, invece, sono cresciuti del 24,9%. Le 32 aziende più grandi del mondo – viene da chiedersi se non siano le stesse che si erano riunite nello US Business Roundtable – hanno guadagnato 109 miliardi in più del solito durante la pandemia; Amazon, in testa, ha visto i propri introiti aumentare del 53%. Che piaccia o no, questo è il modo in cui il capitalismo funziona a pieno regime. Chi si aspetta una parabola eternamente ascendente verrà continuamente smentito dai fatti. Senza crisi, non c’è capitalismo.
Del resto, chi confonde il normale percorso del capitalismo coi sintomi del suo malfunzionamento finisce per ritrovarsi nella stessa posizione di chi intravede in ogni crisi l’imminente collasso del sistema economico, ovvero senza prospettive politiche credibili. Una volta che si è assunto come problema il malfunzionamento del capitalismo, le proposte che seguono sono sempre le stesse: tassazioni strategiche, regolamentazione della finanza, manovre distributive, corporativismo. In poche parole, buon vecchio riformismo. Un esempio lampante di questa linea di pensiero è l’ultimo libro di Yanis Varoufakis, Another Now. Riflettendo a partire dall’esperienza pandemica, l’economista greco si immagina di far tornare a funzionare gli ingranaggi del sistema trasformandolo in un “corpo-sindacalismo”. Si tratta sostanzialmente di un socialismo di mercato in cui il lavoro non è più una merce e in cui tutti i lavoratori possono accedere, attraverso un conto in banca gratuito, a una parte dei dividendi dell’azienda che li impiega. La tassazione, per quanto pesante, riguarda solo i profitti delle suddette corporazioni e il possesso temporaneo della terra. Lo sviluppo del Sud del mondo si ottiene applicando un’imposta su importazioni ed esportazioni al fine di mantenere le bilance commerciali in equilibro.
Anche ammettendo che un tale sistema possa funzionare, non si può fare a meno di notare un’assenza ingombrante: quella della lotta di classe. Sia chiaro, questa non è mai un postulato aprioristico che vada introdotto per adesione di fedeltà a una teoria; è, al contrario, un dato di fatto costitutivo e ineliminabile dello stesso capitalismo, e non è un caso se negli ultimi tempi sta riemergendo con sempre più forza in tutto il mondo (si vedano le rivolte in India, Stati Uniti, Indonesia, Francia, Ecuador, Cile, etc.). Certo, non crediamo che questa rimozione sia un caso. Progetti come quelli di Varoufakis, Wolf, Piketty, Mazzuccato e simili mirano precisamente a espungere dall’equazione l’inconveniente della conflittualità fra classi. In fin dei conti, il capitalismo è il loro punto di partenza e anche il loro punto d’arrivo. Non c’è bisogno di rottura, c’è bisogno di salvare la faccia al sistema che già abbiamo, al massimo di renderlo più inclusivo e più sostenibile. Tutto deve cambiare affinché nulla cambi.
È vitale non farsi trarre in inganno da queste suggestioni. Non solo mistificano la realtà – abbiamo visto che il capitalismo sta funzionando benissimo – ma offuscano anche il potenziale rivoluzionario che ogni crisi porta con sé. Interpretare la crisi come passaggio fisiologico del ciclo economico non significa deporre le armi e proclamare l’invincibilità del capitale. Tutt’altro. Il capitale è effettivamente vulnerabile in quei momenti. Un organismo può contrarre una malattia ed uscirne con le difese immunitarie rinforzante, ma può anche morirne. I liberal-progressisti che continuano a ripetere lo slogan “il capitalismo non sta funzionando” ci invitano invece a dargli un’ultima possibilità proprio nel momento più propizio per abbatterlo. In questo sta la loro pericolosità e funzionalità allo status quo. Può forse apparire consolatoria l’idea di trovarsi in un capitalismo inceppato o pieno di strani prefissi ed epiteti (tardo-, late-stage, crony, rigged, degenere ecc.); ci fa sentire più a nostro agio, più nel giusto quando lo critichiamo. In realtà si tratta solo di una scusa per defilarsi dalla lotta e abdicare ai propri compiti politici. Evitando di fare i conti con il vero volto del capitale, ci si risparmia la fatica di immaginare e costruire un percorso veramente rivoluzionario che possa superarlo.
Insomma, se a Natale vi regalano Varoufakis, ringraziate, donatelo a una biblioteca e, visto che ci siete, chiedete in prestito dei libri di Marx e Lenin.
Vive in Veneto. Lavora come precario nel mondo della scuola.