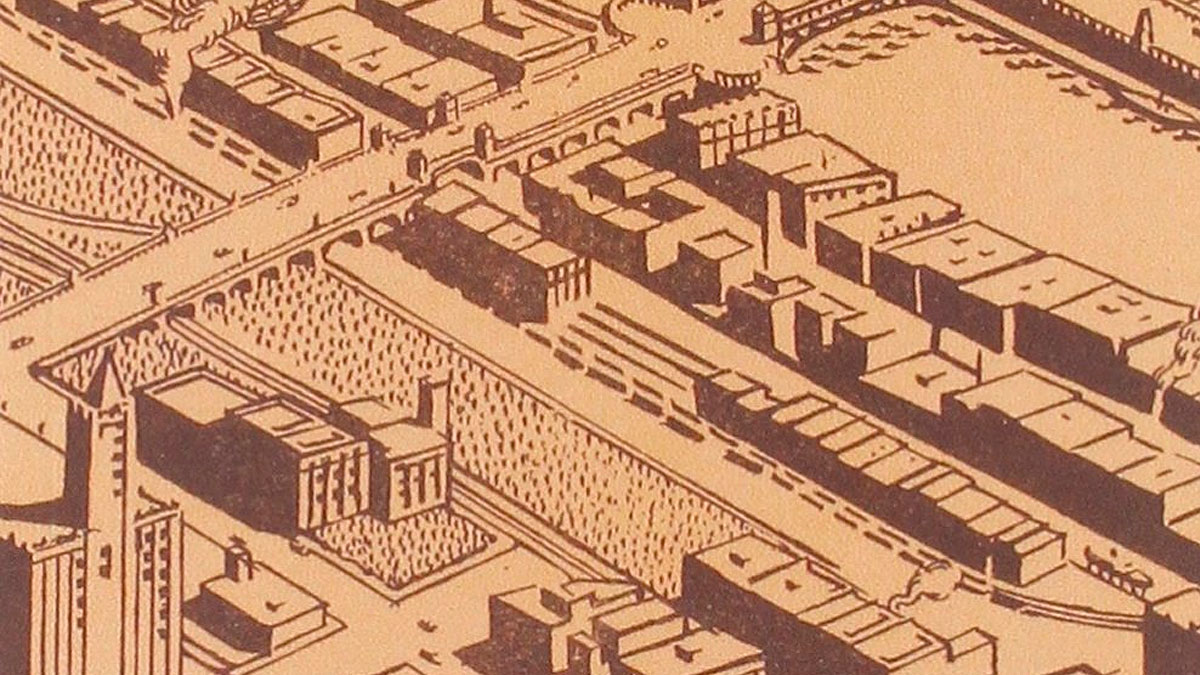Proponiamo la seconda di due parti della traduzione di una conversazione tra Andrea D’Atri e Gastón Remy, intellettuali argentini rivoluzionari, e Corsino Vela, autore di Capitalismo terminal. Potete leggere qui l’introduzione e la prima parte.
Condividiamo la tua lettura delle esperienze di controllo operaio, autogestione e pure delle cooperative operaie, nel senso che tutte esprimono una risposta politica davanti alla crisi, di rottura con il capitale e le sue istituzioni, anche quando l’impossibilità di mantenersi al margine del sistema globale capitalista, le condanni a una forma di precarietà del lavoro, l’auto-sfruttamento e un’economia di sussistenza. Sono senza dubbio esperienze politiche che gettano le fondamenta nelle coscienze di ampi settori e, davanti a questa crisi, probabilmente di milioni di persone. Qual è la tua lettura del ruolo che possono giocare le esperienze di controllo operaio che vengono da altre crisi precedenti (2001 in Argentina, 2009 in Grecia, etc.) in questo nuovo periodo che si apre?
Tutte le esperienze di cooperazione, solidarietà tra eguali e di appoggio mutuo che si danno nella società capitalista sono in maggiore o minor grado delle forme di resistenza alla socializzazione del capitale, che insegue l’individualizzazione e l’isolamento del soggetto produttore/consumatore. In questo senso, le pratiche di controllo operaio sono positive perché sono esperienze che permettono di far emergere in maniera pratica e non solamente teorica le contraddizioni fondamentali legate al processo di proletarizzazione (lavoro, salario, valore d’uso, valore di scambio). E quel che possiamo chiamare una maniera di teorizzazione pratica.
Imparare a non valutare il tempo, lo sforzo, la disponibilità, la conoscenza, le abilità, nel senso di valore, di equivalenza o di scambio.
Le esperienze delle cooperative permettono di sperimentare nella pratica i limiti della cooperazione sociale in condizioni generali di sottomissione ai diktat dell’economia di mercato e al tempo stesso offrono la possibilità di interrogare il senso, il come e il per che cosa di quel che si produce, con un margine di libertà maggiore di quello di qualsiasi lavoro salariato convenzionale.
Una delle vie che apre la situazione attuale di crisi è precisamente, come ho già detto prima, la possibilità di prendere nelle nostre mani le nostre vite, le risorse e i mezzi che le rendono possibili. Qui dunque ci mettiamo di fronte ai limiti pratici dell’autogestione per quel che riguarda la sfera di che cosa produrre, con che mezzi e in che modo. Il cambio essenziale nelle forme di gestione del sistema industriale sotto controllo operaio non rappresenta per se stesso la trasformazione automatica del modo di produzione capitalista. Il sistema produttivo della società industriale non può essere realmente autogestito perché è il risultato di una organizzazione della produzione autoritaria e piramidale, basata nel sistema tecnoscientifico e orientata alla subordinazione dell’essere umano alla macchina; è il sistema di produzione adatto alla società capitalista; gerarchica e autoritaria, complessa (burocratizzata) e di sottomissione sociale (dominazione di classe).
Nel movimento operaio industriale del capitalismo ascendente, l’orizzonte di riappropriazione dei mezzi di produzione rispondeva a un momento storico, ovvero, all’illusione progressista del proletariato che esprimeva in questo modo la dominazione formale del capitale attraverso l’incorporazione nel proletariato dell’ideologia borghese del progresso e l’entusiasmo per le macchine “liberatrici” del lavoro.
Indubbiamente l’esperienza storica della lotta di classe ci insegna che nel sistema capitalista di produzione di beni e servizi non è possibile riappropiarsi né riconvertire tutto. Pensiamo semplicemente ai complessi industriali produttori di nocività, petrolchimici, nucleari o nelle tecniche di riproduzione agroindustriali. Ovviamente l’idea di una emancipazione dell’umanità proletarizzata già è inseparabile dalla sua liberazione dell’universo macchinario ereditato dal modo di produzione capitalista. I luddisti non distruggevano le macchine semplicemente per la loro naturale resistenza alla sottomissione salariale, ma perché attentavano le condizioni di vita dalla comunità. E lì è dove radica il profondo significato della loro lotta.
In qualsiasi caso, è fondamentale introdurre nella critica del capitale, inteso come relazione sociale, la critica all’industrializzazione, alla tecnologia e alla scienza come categorie e pratiche determinanti della dominazione di classe, capziosamente incorporate nella coscienza della popolazione proletarizzata.
Nel libro segnali in che maniera il capitalismo “scalcia la crisi avanti”, però ogni crisi è più profonda e ha meno possibilità di risolversi delle precedenti. In questo senso, dimostri come il “fordismo disperso” e lo sviluppo del terzo settore furono un tentativo per recuperare dalla crisi della metà degli anni 70, e per questo, un tentativo esaurito (e probabilmente questo esaurirsi si è accelerato violentemente con questa crisi sanitaria). In questo processo, segnali un aspetto che ora mi sembra che ha una grande attualità: in che maniera una economia specializzata nell’industria della mobilità rafforza il carattere dipendente dello Stato rispetto alla catena mondiale d’accumulazione capitalista. Ci piacerebbe che tu sviluppassi questo concetto e come vedi che questo fattore agisce sulla situazione presente e, in particolare, in prospettiva in che maniera si può prevedere una dislocazione delle forme di produzione che ha assunto il capitale negli ultimi 30 anni.
Effettivamente il ciclo di ristrutturazione e di accumulazione del capitale degli ultimi tre decenni, che ha già dato i suoi primi segnali di sfinimento con la crisi del 2008, ora sembra destinato alla sua fine. Per quel che riguarda l’industria della mobilità, si deve distinguere tra due sotto-settori della stessa: quello della mobilità regionale e locale, come conseguenza della dispersione produttiva a piccola scala, che induce attività per quel che riguarda l’uso dell’automobile, autostrada, industria ausiliare meccanica e di servizio, etc…E l’altro settore, quello dell’industria e del business della mobilità turistica.
La strategia di delocalizzazione produttiva ha stimolato la mobilità delle merci e delle forze di lavoro da tutti i livelli, tanto mondiali come regionali, con milioni di spostamenti regionali giornalieri. Però adesso si osserva che si è trasformata in un’opzione insostenibile economicamente, così come si è visto chiaramente con le mobilitazioni dei gilets jaunes in Francia; operativamente per l’interruzione degli scambi commerciali internazionali e la saturazione dei corridoi delle conurbazioni, e dal punto di vista ambientale per l’impatto sul cambio climatico.
Inoltre le misure per tentare di frenare la pandemia sono rimbalzate immediatamente sulle catene di somministrazione con un’incidenza paralizzante sulle economie regionali e nazionali. Tanto i paesi produttori (Cina) come quelli di assemblaggio e consumatori sono restati immobilizzati dagli effetti a cascata della catena logistica, sia nella catena superiore (somministrazione della componentistica) che in quella sottostante (distributori di prodotti finiti).
Si è dimostrata tutta la vulnerabilità a scala mondiale della catena logistica e dell’accumulazione di capitale.
Il mantenimento dei servizi minimi o delle attività essenziali per la catena di somministrazione degli alimenti e delle industrie ausiliarie in uno stato d’emergenza, ha fatto emergere chiaramente la fragilità strutturale della catena e della capacità di manovra di ogni paese nel momento di sovvenire alle necessità più urgenti della popolazione.
Quel che voglio dire chiaramente è che la catena di dipendenza dei paesi fa sì che dagli organi del potere politico, economico e accademico si inizi a mettere in dubbio e si parli di rilocalizzazione o di spingere la produzione nazionale. Di fatto, molti paesi consumatori si son visti incapaci di fabbricare o di riconvertire la propria industria verso la produzione sanitaria, né di produrre respiratori usati nelle UCI (Unità di Cure Intensive), né di avere delle mascherine o delle uniformi di protezione per il personale sanitario.
È difficile prevedere al dettaglio come si concretizzerà la ristrutturazione generale dell’ordine mondiale capitalista che ha fatto esplodere la pandemia del coronavirus. Pero è probabile che qualche paese cerchi di ridurre la sua dipendenza dalla catena produttiva transnazionale attraverso un processo di rilocalizzazione di qualcuna delle sue industrie e delle sue attività produttive, approfittando che la riduzione dei costi salariali sulla quale si articolerà la chiamata allo “sforzo per la ricostruzione dell’economia nazionale” trasformi in maggior profitto la produzione di merci che furono delocalizzate nel decennio 1980/90. Dunque si tratterà di verificare fino a che punto è possibile in un modello di produzione nazionale spingere indietro l’orologio della storia e ritornare alla rilocalizzazione delle attività economiche. E soprattutto come ripercuoterà sul processo generale d’accumulazione di capitale se, così come stiamo già vendendo, gli Stati da soli sono impotenti per far fronte a una situazione d’emergenza delle dimensioni create dal coronavirus-19.
Nell’immediato, e sotto effetto pandemia, come vedi le prospettive del settore del turismo che così come spieghi nel tuo libro ha giocato un ruolo preponderante nella recupero economico di vari stati europei dopo la crisi del 2008?
Le restrizioni della mobilità e il timore generalizzato attorno alla pandemia hanno paralizzato totalmente l’attività turistica. Il turismo è un negozio che dipende dalla capacità acquisitiva dei consumatori ma che, come vediamo, non è un settore delle attività economiche essenziali; non è una merce di prima necessità. Come settore economico determinante dei paesi di seconda categoria della catena d’accumulazione di capitale transnazionale, dipende dal potere acquisitivo dei consumatori dei paesi capitalisti più sviluppati.
L’eventuale recupero del settore turistico a breve termine dipenderà dunque dalla rapidità con la quale si ristabilirà la normalità acquisitiva nelle democrazie dei consumatori. Però, per tutto quel che ho detto finora, tutto fa pensare che non sarà facile e così sembra indicare la preoccupazione che espressa l’imprenditoria del settore turistico. Senza dubbio scomparirà la piccola azienda e ci sarà una grande concentrazione del business in un settore che di per sé è già concentrato in pochi gruppi. Diversi paesi, che hanno un PIL che dipende in gran parte dal turismo, non ritorneranno mai più a una situazione come quella anteriore alla pandemia. Il che non è male se pensiamo agli effetti devastatori del turismo.
Devo dire che un’ipotetica riconversione capitalista delle attività turistiche è una questione complicata per la natura specifica della sua infrastruttura, per il suo basso livello tecnologico e per il suo basarsi su una manodopera con bassa specializzazione. È chiaro che l’infrastruttura inservibile per il business turistico potrebbe essere approfittata per alloggiare a tutte quelle persone senza casa e alleviare il grave problema della casa, ma questo naturalmente non entra nei calcoli dei proprietari dei complessi turistici nei dei gestori politici che solamente attraverso l’espropriazione potrebbero portare a compimento una politica abitativa senza disequilibrare pericolosamente il deficit pubblico.
In nessun caso il turismo potrà giocare il ruolo che ha avuto nell’era della ristrutturazione capitalista del finale del XX secolo, come indennizzo della delocalizzazione industriale di vari paesi. All’impoverimento generale della popolazione salariata, che ridurrà la domanda mondiale della mobilità, ci sarà da aggiungere i problemi di finanziarizzazione dei nuovi business o dei settori economici in un contesto di caduta d’accumulazione di capitale e il rincaro prevedibile dell’energia, come conseguenza dello sfinimento delle riserve e dell’aumento dei costi di sfruttamento delle stesse.
In mezzo alla baraonda economica provocata dalla pandemia, l’ossigeno che potrebbe venire dallo straordinario abbassamento del prezzo del petrolio è solo un miraggio dovuto alle conseguenze della battaglia tra la Russia e gli Stati Uniti.
Al tempo stesso, nel tuo libro dici che la vulnerabilità delle organizzazioni del fordismo disperso conferisce forza a gruppi ridotti però concentrati di lavoratori con funzioni critiche. Noi parliamo di settori del proletariato con “posizioni strategiche” che evidentemente si sono aperti a nuovi settori dei servizi. Segnali i lavoratori di porti, aeroporti, trasporti in generale e la logistica. Nel quadro dei cambi che possono darsi con l’esaurirsi a livello mondiale dello schema di produzione decentrata, quale può essere il futuro di questi settori che assunsero un peso insolito nella struttura economica contemporanea?
Prima di tutto è necessario ricordare che la decentralizzazione produttiva ha una doppia finalità per quel che riguarda la disgregazione delle relazioni di lotta tra i lavoratori e l’abbattimento dei costi attraverso l’esternalizzazione delle attività verso aziende subappaltate. È stata precisamente questa la risposta all’esaurirsi della strategia fordista di concentrazione dei lavoratori nelle grandi fabbriche: ma ora risulta che la soluzione di ieri è il problema di oggi. Per questo, nell’ordine strettamente produttivo, industriale, una possibile ricentralizzazione produttiva ha dei limiti in ogni settore e in ogni attività e prodotto.
D’altro canto, i servizi strategici relazionati per esempio con la logistica, i trasporti, la manutenzione e la pulizia, stanno in stretta dipendenza con il sistema produttivo. Nella misura in cui quest’ultimo si contrae, si ridurrà anche l’attività nei servizi che danno un’uscita di mercato ai prodotti. Il livello di estensione che avranno questi servizi in un futuro vicino dipenderà dunque dall’evoluzione della produzione industriale e della domanda sociale. Continuerà a esserci una relativa proporzione tra produzione delocalizzata e rilocalizzata soprattutto se, com’è prevedibile, nel processo di ristrutturazione nel quale già ci troviamo si crea il fronte comune per ricostruire l’economia nazionale e si porta a compimento il piano di sacrificio dei lavoratori attraverso l’abbattimento dei costi di manodopera.
Indubbiamente, così come emerge nell’attuale stato di emergenza, tutti questi servizi sono essenziali allo stesso livello per la riproduzione sociale, aldilà della sfera industriale. La loro importanza strategica si vede rafforzata, come servizi socialmente necessari, ma di prima necessità. Arrivati a questo punto voglio richiamare l’attenzione sull’apparente rivalorizzazione sociale di questi servizi e in particolar modo su quelli della cura. Tutti gli apparati mediatici si sono prodigati in elogi senza fine per gli eroi della pandemia (personale sanitario, dei supermercati, dei trasporti, etc.). È come se improvvisamente, avessimo scoperto che migliaia di uomini e donne sommerse in modeste attività, fortemente precarizzate e per niente spettacolari o creative, svolgono un lavoro decisivo e realmente necessario per la vita. Ho i miei dubbi sul fatto che quelle persone che alle otto della sera compiono il rituale di affacciarsi al balcone e applaudire a questo settore di lavoratori pieni d’abnegazione, si siano chieste qualche volta quali sono le condizioni di lavoro di queste persone così mediaticamente eroicizzate. E soprattutto, se saranno solidali quando coloro che oggi sono elogiati saranno esclusi dagli sguardi dei media.
Sia come sia, tra i molti aspetti che ha fatto emergere la propagazione del coronavirus-19 segnalerei quello che si riferisce alla riproduzione sociale, alle attività concrete di sopravvivenza e di cura, e metterlo in prima fila della nostra realtà politica.
Il protagonismo di queste donne e uomini, lavoratori dei servizi strategici nel processo di produzione e realizzazione delle merci, è in queste circostanze strategico per la conservazione della vita delle persone. Le implicazioni teoriche e pratiche di tutto questo portano direttamente a interrogarci con tutta la radicalità che la situazione esige intorno al lavoro, ovvero, intorno al lavoro socialmente necessario e alla sua relazione con la vita umana che, nelle condizioni attuali di sottomissione alla valorizzazione del capitale, non ha altro orizzonte che quello della sua preparazione per il prossimo disastro.
Corsino Vela è lo pseudonimo di un militante operaio nato in Asturia nel 1953 che risiede attualmente in Catalogna. La sua militanza politica iniziò alla fine degli anni ‘70 nel processo di costituzione del sindacato Confederación Nacional del Trabajo (CNT). È autore dei libri, tutti pubblicati in spagnolo, La sociedad implosiva (Muturreko Burutazioak, 2015), Capitalismo terminal (Traficantes de Sueños, 2018) e del libro collettivo No le deseo un estado a nadie (Pepitas de Calabaza, 2018).
Nata nel 1967 a Buenos Aires, dove tuttora vive. Laureata in Piscologia alla UBA, specializzata in Studi sulla Donna, ha lavorato come ricercatrice, docente e nel campo della comunicazione. È dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Militante di lungo corso del movimento delle donne, nel 2003 ha fondato la corrente Pan y Rosas in Argentina, che ha una presenza anche in Cile, Brasile, Messico, Bolivia, Uruguay, Perù, Costa Rica, Venezuela, Germania, Spagna, Francia, Italia.
Ha tenuto conferenze e seminari in America Latina ed Europa.
Autrice di "Pan y Rosas", pubblicato e tradotto in più paesi e lingue. Ha curato il volume "Luchadoras. Historias de mujeres que hicieron historia" (2006), pubblicato in Argentina, Brasile, Venezuela e Spagna (2006).